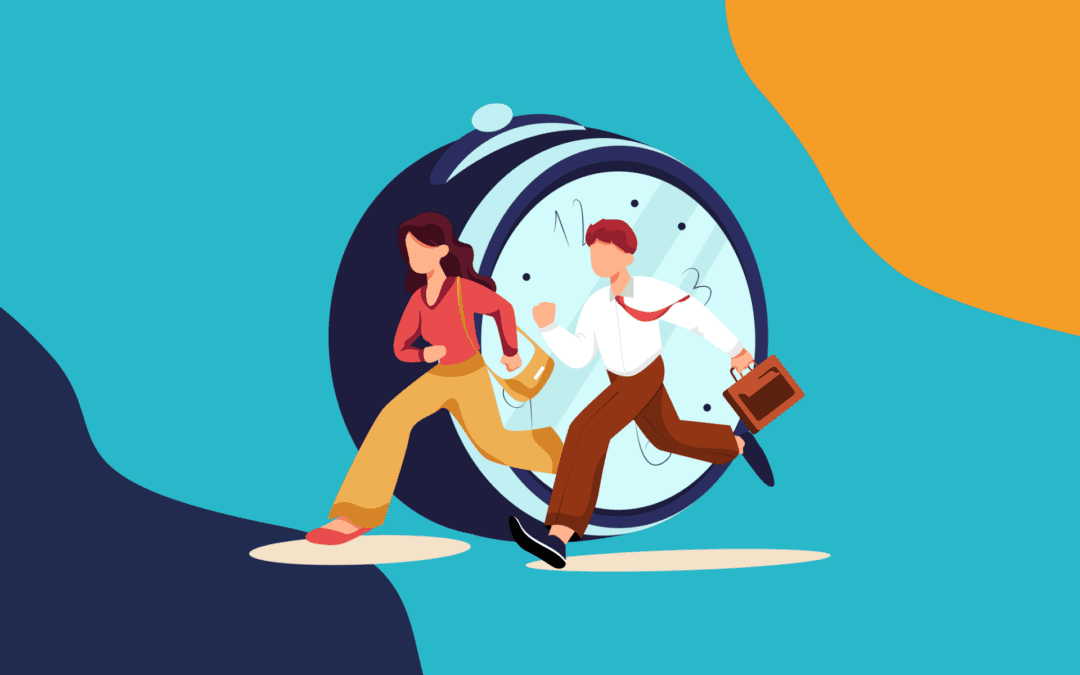Come le aziende vincono o perdono la sfida sociale
Nell’ultimo decennio, si è sviluppato nella società un maggior senso di responsabilità civile: cause sociali, ambientali, politiche ed etiche partono sempre più dai singoli che dalle istituzioni, tramite manifestazioni pubbliche, petizioni online o campagne social. Ne è un esempio il sito Change.org, dove chiunque può lanciare e sponsorizzare una petizione, raccogliendo firme e consensi a livello internazionale. Questa situazione si è creata a causa di diversi fattori psico-sociologici: il calo di fiducia nelle istituzioni governative, la maggiore coscienza di sé dei consumatori più giovani, il passaggio da parte dei brand a un marketing più relazionale – definito Marketing umanistico, o 3.0 – in contrapposizione con il vecchio modello transazionale.
Di conseguenza, sempre più persone chiedono e si aspettano questo comportamento non solo dagli altri, ma anche e soprattutto da ciò che comprano. Viene chiesto ai brand di prendere una posizione su argomenti sensibili, per allinearsi a livello valoriale con gli acquirenti. Svariati studi confermano infatti una propensione all’acquisto quando brand ben posizionati attuano iniziative di responsabilità sociale e attivismo.
Citando alcuni dati a livello mondiale, l’87% dei consumatori afferma di essere maggiormente intenzionato all’acquisto di un determinato prodotto se l’azienda produttrice supporta una causa in linea con le proprie opinioni. Il 47% dei consumatori italiani dichiara di aver smesso di comprare un prodotto come risposta ad azioni del brand o a causa del contrasto di valori.
Le aziende, dunque, sono portate e quasi moralmente obbligate a perseguire ideali prosociali con la comunicazione e azioni concrete, sia per portare benefici al brand in termini di immagine e reputazione, che per differenziarsi dai competitor. Entrambi gli aspetti possono normalmente tradursi in un ritorno economico non indifferente. Un celebre esempio è la campagna di Nike fatta in collaborazione con il giocatore di football Colin Kaepernick. Nel 2016, l’atleta si inginocchiò durante l’inno in protesta contro la violenza della polizia nei confronti della comunità afroamericana. Il brand statunitense si affiancò a Kaepernick nella sua battaglia, dividendo il Paese e sollevando un gran polverone: molti clienti abituali non approvarono questa scelta, bruciando le proprie sneakers e cercando di boicottare l’azienda. Nonostante tutto, molte più persone sostennero la causa di Nike, facendo aumentare, malgrado le polemiche, le vendite del 31%.
Queste attività – una sorta di evoluzione della vecchia CSR (Corporate Social Responsibility) – vengono definite Brand activism. Il Brand activism viene definito da Philip Kotler e Christian Sarkar nel libro “Brand activism. Dal purpose all’azione” come la volontà chiaramente esplicitata di partecipare a cause in ambito sociale, oltre che di assumersi precise responsabilità in merito al raggiungimento di quello che viene considerato bene comune. Vengono identificate 6 tipologie di attivismo e 7 aree critiche d’intervento, tra loro interconnesse.
Le 6 tipologie sono:
- l’attivismo sociale, legato ai diritti umani, come le discriminazioni di genere, età, etnia o orientamento sessuale;
- l’attivismo aziendale, riguardo la governance, i diritti dei lavoratori o il welfare;
- l’attivismo politico, il quale copre temi come il diritto di voto, le politiche migratorie e il lobbismo
- l’attivismo ambientale, che si occupa di tutte le tematiche ecologiche;
- l’attivismo economico, legato alle politiche fiscali, il salario minimo, la ridistribuzione della ricchezza;
- l’attivismo giuridico, volto a incoraggiare normative riguardanti l’occupazione, le condizioni di lavoro o l’inclusione.
Le 7 aree sono:
- il cambiamento climatico;
- la disuguaglianza;
- l’estremismo e l’intolleranza;
- le migrazioni;
- la corruzione e la disonestà;
- l’istruzione;
- la crescita demografica e l’accesso alle risorse.
Negli ultimi 3 anni, l’evoluzione del mercato e delle sue dinamiche ha preparato un terreno estremamente fertile per dar vita all’attivismo dei brand, fino a diventare non più una decisione conscia e studiata, quanto più dettata dal trend. Questo ha portato una grande parte dei consumatori a dubitare dell’autenticità di alcuni messaggi e campagne, dato che molti brand utilizzano temi sensibili esclusivamente a fini prettamente commerciali, senza effettuare azioni rilevanti verso i valori sostenuti. Questa tendenza di appropriarsi di cause sociali, viene identificata con il nome di Woke washing. Il termine deriva da Woke, svegliato, cosciente, e Washing, lavaggio: la combinazione delle parole può essere tradotta come “lavarsi la coscienza”, intesa con accezione negativa. Il Woke washing diventa tale quando l’utente si accorge di una discrepanza tra messaggio e azione, quindi la percezione tra azione e predicazione non corrisponde.
Vediamo quali sono le tipologie più comuni di Woke washing.
Green Washing
La forma più comune di Washing è quella legata a tematiche ambientali. Le aziende mostrano un lato eco-friendly, comunicando un cambiamento dei processi, una minimizzazione dell’impatto ambientale o semplicemente una vicinanza ai temi. Un esempio può essere quello di McDonald’s che abbandona il rosso dei suoi sfondi per adottare un verde foresta e dichiara che entro il 2025 tutti i suoi imballaggi saranno realizzati con materiali riciclati e sostenibili. In risposta, uno studio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha evidenziato che, in Italia, rappresentano però la seconda causa di inquinamento da polveri sottili e l’aumento di allevamenti intensivi. Quest’ultimi sono una causa diretta della deforestazione in Amazzonia. Tramite il lavaggio verde, McDonald’s non solo non ha valorizzato la propria brand equity, ma ha attirato su di sé polemiche e azioni di boicottaggio.
Un altro esempio è quello di Lacoste: il fashion brand francese, nel 2018, sostituisce su oltre 1700 polo bianche il famoso coccodrillo, rimpiazzandolo con diverse specie in via d’estinzione, per sensibilizzare i consumatori alla tematica. L’azione, sostenuta e apprezzata in primis dal pubblico, ha suscitato un certo fastidio in alcune associazioni animaliste. Infatti, l’azienda produce e vende online alcuni capi d’abbigliamento di origine animale, come borse in pelle di mucca e guanti in pelle di cervo.
Rainbow Washing
Un’altra tipologia di Washing che si è fatta strada negli ultimi anni riguarda i diritti e le lotte della comunità LGBTQIA+.
A giugno, in occasione del Pride Month, vengono proposte comunicazioni in linea alle tematiche della discriminazione sessuale, il matrimonio omosessuale o la vicinanza alla comunità, utilizzando il simbolo o i colori dell’arcobaleno. Nel 2021, Primark lancia la collezione Feeling proud, suscitando indignazione in moltissimi utenti, visto che i capi d’abbigliamento vengono prodotti perlopiù in Bangladesh, Paese dove l’omosessualità è punibile con l’ergastolo. Lo stesso è valso per la produzione bengalese di H&M. Anche alcune aziende come Microsoft, Amazon e UPS hanno donati milioni di dollari a politici apertamente anti-LGBT. In contrasto al Rainbow washing, è nato il movimento #WhoMadeMyPrideMerch, un profilo social a opera di Izzy McLeod che denuncia i brand che utilizzano le realtà queer e le loro battaglie solo a scopo commerciale.
Pink Washing
La terza categoria di Washing facilmente riscontrabile si lega a tematiche come l’emancipazione femminile, la sensibilizzazione al tumore al seno, alla disparità di genere o la body positivity.
Un esempio di lavaggio non riuscito è quello dello spot Audi per il Super Bowl 2017: il commercial “Daughter” sottolinea attraverso uno storytelling emozionale ed empatico una corsa di kart dove una ragazzina primeggiava contro gli altri bambini maschi. Audi cerca di lanciare un messaggio positivo, sottolineando la necessità di colmare il gender gap e di sfatare gli stereotipi di genere. L’intera comunicazione è stata smantellata dalla constatazione riguardo la pressoché assenza di lavoratrici donne in posizioni di rilievo e/o esecutive in Audi.
Anche Mattel è stata criticata più volte a causa della responsabilità che ha avuto fin dalla sua creazione nel perpetrare uno stereotipo di bellezza femminile non sano. Nonostante abbia cercato spesso di controbilanciare creando Barbie curvy, in sedia a rotelle, di colore o ungendered, l’azienda non è mai riuscita a trasformare le sue azioni in vero attivismo.
La linea che divide il Brand activism e il Woke washing è davvero sottile: sono davvero infinite le varianti e quindi le possibilità di cadere in errore. È quindi possibile fare attivismo in modo corretto e virtuoso? Ecco alcuni casi studio di campagne di successo che si sono rivelate edificanti e proficue per i brand.
Patagonia
Il caso più significativo di Brand activism è sicuramente quello attuato dal brand Patagonia. L’azienda, specializzata in abbigliamento sportivo e da esterni, è attiva da oltre un decennio nella salvaguardia dell’ambiente e nella conservazione del territorio, lotta contro alcune azioni politiche statunitensi ed è in prima linea nella campagna Stop Hate for Profit contro Facebook e Instagram. Il brand californiano dona l’1% delle sue vendite totali annue a gruppi ambientalisti attraverso One Percent for the Planet, organizzazione di cui Yvon Chouniard, creatore di Patagonia, è stato co-fondatore. Ma c’è di più, nel 2016, l’azienda ha devoluto anche il 100% delle vendite ricavate dal Black Friday.
La produzione del 40% dei capi è centralizzata in stabilimenti certificati Fair Trade, e, per ogni articolo prodotto, viene versato un bonus monetario in un conto controllato dai lavoratori stessi degli stabilimenti. L’azienda ha anche attivato dei centri per la riparazione e il riciclaggio dei capi usati, realizzando documentari su questo processo e contro il consumismo per sensibilizzare sulla tematica.
Ikea
Anche il brand svedese IKEA è da sempre attivo in campagne per promuovere temi ecologici e produzioni a basso impatto ambientale. Oltre la cartellonistica sempre presente in ogni punto vendita che ricorda al cliente come l’azienda fa di tutto per rendere l’intero processo produttivo e di vendita sostenibile ed economico, ogni anno IKEA produce un “bilancio di sostenibilità” in cui illustra i risultati raggiunti dai programmi attuati e gli obiettivi futuri, sia in campo ambientale che sociale. Tra questi progetti, ricordiamo la campagna “Compostiamoci bene” per la riqualificazione del territorio italiano, #fateloacasavostra in sostegno della comunità LGBTQIA+ e dell’associazione Quore, o “La casa non è fatta per difendersi” contro la violenza domestica con il supporto di Telefono Donna.
BIANCO.
Un altro esempio è la campagna del brand di scarpe BIANCO., che nel 2018 lancia “Hate is so 2018”. La campagna prende come spunto iniziale l’odio e i punti bassi sociali e umanitari dell’anno, andando contro, in maniera più o meno esplicita, al cyberbullismo, alla politica di Trump, ai gruppi omofobi e all’estremismo religioso. La sola campagna ha fatto molto discutere, non solo donando al brand una maggiore notorietà a livello globale, ma anche facendo registrare un aumento delle vendite. Il brand, inoltre, ha sempre adottato misure eco-friendly nella sua produzione, promuovendo la gender equality e l’amore in tutte le sue forme. “Hate is so 2018” ha fatto aumentare le vendite del brand danese, aumentandone esponenzialmente l’awareness e la popolarità sui social.
Il mantra più ripetuto nella comunicazione e nel marketing degli ultimi anni è: “le aziende non possono più star ferme e non prendere una posizione”, e questo ormai non si ripercuote più solo sulle multinazionali, come per gli esempi sopracitati, ma anche sulle PMI. Ecco alcuni consigli su come le piccole-medie imprese possono approcciarsi al Brand activism:
- attivare una sola campagna alla volta, divulgandola attraverso i canali di comunicazione e parlandone one-to-one con i clienti, rendendo l’operazione più umana e genuina;
- scegliere un campo d’azione vicino alla propria identità e storia, puntando anche a opere e realtà territoriali;
- distanziarsi concettualmente da ciò che fanno altre aziende e realtà geograficamente vicine, per non creare una falsa concorrenza e venire confusi dal consumatore.
Se anche voi volete approcciarvi all’attivismo aziendale, vi lasciamo 6 semplici accortezze per far sì che le vostre azioni non siano percepite solo come di facciata e quindi cadere sempre in piedi:
- scegliete bene la causa da sostenere e assicuratevi che sia coerente con la vostra storia, i vostri valori e ciò che è stato svolto in passato;
- siate chiari e trasparenti riguardo alle motivazioni della vostra campagna di attivismo;
- valutate bene i rischi reputazionali e capite quale fascia di clienti potete acquisire o perdere;
- fate maggiore attenzione alle azioni che alle parole;
- non cercate per forza di essere provocatori o creativi, soprattutto quando ci sono in gioco temi delicati o molto caldi;
- trovate una buona strategia di crisis management in caso di controversie.
Spesso cadiamo nell’errore di credere che le grandi aziende abbiano maggiori possibilità di intraprendere azioni comunicative e di marketing più valoriali che commerciali. In realtà, le PMI sono agevolate perché non hanno bisogno di rendere il proprio brand più “umano” e possono attivarsi con budget e sforzi decisamente ridotti, a volte anche a costo zero. Inoltre, considerando il mercato, hanno una possibilità maggiore di differenziarsi grazie al Brand activism, assumendo però minori rischi reputazionali.